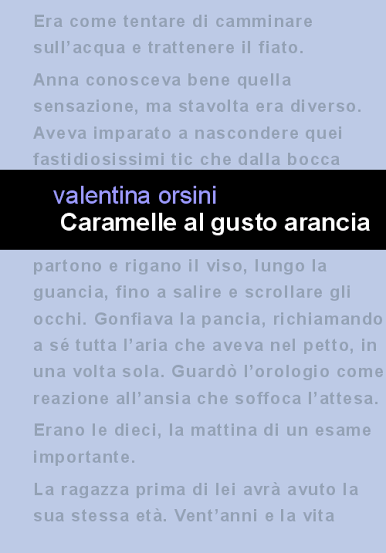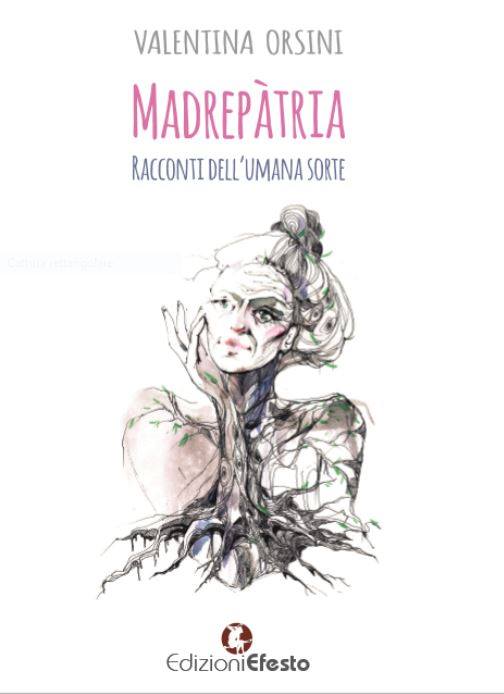Nel giugno del 1964, Einaudi propone a Italo Calvino una nuova edizione de Il sentiero dei nidi di ragno. Suo primo romanzo, pubblicato nel 1947. In questa prefazione/presentazione, l'autore riflette sulla propria opera, raccontando la Resistenza, in quanto testimone e protagonista egli stesso.
Non è pienamente soddisfatto Calvino e, a detta sua, quel primo romanzo non è riuscito a cogliere appieno, il significato della Resistenza. Cosa che invece è riuscita bene, sempre a detta di Calvino, a Beppe Fenoglio, con Una questione privata.
E oggi, giorno celebrativo di quel 25 aprile del 1945, io ho deciso di condividere con voi questo testo nato come "revisione", e divenuto poi una seconda opera, di altrettanta importanza storica e letteraria.
(Solo Calvino aveva questo dono).
Ambientato in Liguria, nei giorni della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza Partigiana, Il sentiero dei nidi di ragno è un romanzo dai toni fiabeschi, raccontato di "sbieco", filtrato dagli occhi di un bambino. Pin.
[...] La mia storia era quella dell’adolescenza durata troppo a lungo, per il giovane che aveva preso la guerra come un alibi, nel senso proprio e in quello traslato. Nel giro di pochi anni, d’improvviso l’alibi era diventato un qui e ora. Troppo presto, per me; o troppo tardi: i sogni sognati troppo a lungo, io ero impreparato a viverli. Prima, il capovolgersi della guerra estranea, il trasformarsi in eroi e in capi degli oscuri e refrattari di ieri. Ora, nella pace, il fervore delle nuove energie che animava tutte le relazioni, che invadeva tutti gli strumenti della vita pubblica, ed ecco anche il lontano castello della letteratura s’apriva come un porto vicino e amico, pronto ad accogliere il giovane provinciale con fanfare e bandiere. E una carica amorosa elettrizzava l’aria, illuminava gli occhi delle ragazze che la guerra e la pace ci avevano restituito e fatto più vicine, divenute ora davvero coetanee e compagne, in un’intesa che era il nuovo regalo di quei primi mesi di pace, a riempire di dialoghi e di risa le calde sere dell’Italia resuscitata.
Di fronte a ogni possibilità che s’apriva, io non riuscivo a essere quello che avevo sognato prima dell’ora della prova: ero stato l’ultimo dei partigiani; ero un innamorato incerto e insoddisfatto e inabile; la letteratura non mi s’apriva come un disinvolto e distaccato magistero ma come una strada in cui non sapevo da che parte cominciare. Carico di volontà e tensione giovanili, m’era negata la spontanea grazia della giovinezza. Il maturare impetuoso dei tempi non aveva fatto che accentuare la mia immaturità.
Il protagonista simbolico del mio libro fu dunque un’immagine di regressione: un bambino. Allo sguardo infantile e geloso di Pin, armi e donne ritornavano lontane e incomprensibili; quel che la mia filosofia esaltava, la mia poetica trasfigurava in apparizioni nemiche, il mio eccesso d’amore tingeva di disperazione infernale.
Scrivendo, il mio bisogno stilistico era tenermi più in basso dei fatti, l’italiano che mi piaceva era quello di chi «non parla l’italiano a casa», cercavo di scrivere come avrebbe scritto un ipotetico me stesso autodidatta.
Il sentiero dei nidi di ragno è nato da questo senso di nullatenenza assoluta, per metà patita fino allo strazio, per metà supposta e ostentata. Se un valore oggi riconosco a questo libro è lì: l’immagine d’una forza vitale ancora oscura in cui si saldano l’indigenza del «troppo giovane» e l’indigenza degli esclusi e dei reietti.
Se dico che allora facevamo letteratura del nostro stato di povertà, non parlo tanto d’una programmaticità ideologica, quanto di qualcosa di più profondo che era in ciascuno di noi.
Oggi che scrivere è una professione regolare, che il romanzo è un «prodotto», con un suo «mercato», una sua «domanda» e una sua «offerta», con le sue campagne di lancio, i suoi successi e i suoi tran-tran, ora che i romanzi italiani sono tutti «di un buon livello medio» e fanno parte della quantità di beni superflui di una società troppo presto soddisfatta, è difficile richiamarci alla mente lo spirito con cui tentavamo di cominciare una narrativa che aveva ancora da costruirsi tutto con le proprie mani.
Continuo a usare il plurale, ma vi ho già spiegato che parlo di qualcosa di sparso, di non concordato, che usciva da angoli di provincia diversi, senza ragioni esplicite in comune che non fossero parziali e provvisorie. Fu più che altro – diciamo – una potenzialità diffusa nell’aria. E presto spenta.
Già negli Anni Cinquanta il quadro era cambiato, a cominciare dai maestri: Pavese morto, Vittoriani chiuso in un silenzio d’opposizione, Moravia che in un contesto diverso veniva acquistando un altro significato (non più esistenziale ma naturalistico) e il romanzo italiano prendeva il suo corso elegiaco-moderato-sociologico in cui tutti finimmo per scavarci una nicchia più o meno comoda (o per trovare le nostre scappatoie).
Ma ci fu chi continuò sulla via di quella prima frammentaria epopea: in genere furono i più isolati, i meno «inseriti» a conservare questa forza. E fu il più solitario di tutti che riuscì a fare il romanzo che tutti avevamo sognato, quando nessuno più se l’aspettava, Beppe Fenoglio, e arrivò a scriverlo e nemmeno finirlo (Una questione privata), e morì prima di vederlo pubblicato, nel pieno dei quarant’anni. Il libro che la nostra generazione voleva fare, adesso c’è, e il nostro lavoro ha un coronamento e un senso, e solo ora, grazie a Fenoglio, possiamo dire che una stagione è compiuta, solo ora siamo certi che è veramente esistita: la stagione che va dal Sentiero dei nidi di ragno a Una questione privata.
Una questione privata (che ora si legge nel volume postumo di Fenoglio Un giorno di fuoco) è costruito con la geometrica tensione d’un romanzo di follia amorosa e cavallereschi inseguimenti come l’Orlando furioso, e nello stesso tempo c'è la Resistenza proprio com’era, di dentro e di fuori, vera come mai era stata scritta, serbata per tanti anni limpidamente dalla memoria fedele, e con tutti i valori morali, tanto più forti quanto più impliciti, e la commozione, e la furia. Ed è un libro di paesaggi, ed è un libro di figure rapide e tutte vive, ed è un libro di parole precise e vere. Ed è un libro assurdo, misterioso, in cui ciò che si insegue, si insegue per inseguire altro, e quest'altro per inseguire altro ancora e non si arriva al vero perchè.
E’ al libro di Fenoglio che volevo fare la prefazione: non al mio.
Questo romanzo è il primo che ho scritto, quasi la prima cosa che ho scritto. Cosa ne posso dire, oggi? Dirò questo: il primo libro sarebbe meglio non averlo mai scritto.
Finché il primo libro non è scritto, si possiede quella libertà di cominciare che si può usare una sola volta nella vita, il primo libro già ti definisce mentre tu in realtà sei ancora lontano dall’esser definito; e questa definizione poi dovrai portartela dietro per la vita, cercando di darne conferma o approfondimento o correzione o smentita, ma mai più riuscendo a prescinderne.
E ancora: per coloro che da giovani cominciarono a scrivere dopo un’esperienza di quelle con «tante cose da raccontare» (la guerra, in questo e in molti altri casi), il primo libro diventa subito un diaframma tra te e l’esperienza, taglia i fili che ti legano ai fatti, brucia il tesoro di memoria – quello che sarebbe diventato un tesoro se avessi avuto la pazienza di custodirlo, se non avessi avuto tanta fretta di spenderlo, di scialacquarlo, d’imporre una gerarchia arbitraria tra le immagini che avevi immagazzinato, di separare le privilegiate, presunte depositarie d’una emozione poetica, dalle altre, quelle che sembravano riguardarti troppo o troppo poco per poterle rappresentare, insomma d’istituire di prepotenza un’altra memoria, una memoria trasfigurata al posto della memoria globale coi suoi confini sfumati, con la sua infinita possibilità di recuperi… Di questa violenza che le hai fatto scrivendo, la memoria non si riavrà più: le immagini privilegiate resteranno bruciate dalla precoce promozione a motivi letterari, mentre le immagini che hai voluto tenere in serbo, magari con la segreta intenzione di servirtene in opere future, deperiranno, perché tagliate fuori dall’integrità naturale della memoria fluida e vivente. La proiezione letteraria dove tutto è solido e fissato una volta per tutte, ha ormai occupato il campo, ha fatto sbiadire, ha schiacciato la vegetazione dei ricordi in cui la vita dell’albero e quella del filo d’erba si condizionano a vicenda. La memoria – o meglio l’esperienza, che è la memoria più la ferita che ti ha lasciato, più il cambiamento che ha portato in te e che ti ha fatto diverso -, l’esperienza primo nutrimento anche dell’opera letteraria (ma non solo di quella), ricchezza vera dello scrittore (ma non solo di lui), ecco che appena ha dato forma a un’opera letteraria insecchisce, si distrugge. Lo scrittore si ritrova ad essere il più povero degli uomini.
Così mi guardo indietro, a quella stagione che mi si presentò gremita d’immagini e di significati: la guerra partigiana, i mesi che hanno contato per anni e da cui per tutta la vita si dovrebbe poter continuare a tirar fuori volti e ammonimenti e paesaggi e pensieri ed episodi e parole e commozioni: e tutto è lontano e nebbioso, e le pagine scritte sono lì nella loro sfacciata sicurezza che so bene ingannevole, le pagine scritte già in polemica con una memoria che era ancora un fatto presente, massiccio, che pareva stabile, dato una volta per tutte, l’esperienza, - e non mi servono, avrei bisogno di tutto il resto, proprio di quello che lì non c’è. Un libro scritto non mi consolerà mai di ciò che ho distrutto scrivendolo: quell’esperienza che custodita per gli anni della vita mi sarebbe forse servita a scrivere l’ultimo libro, e non mi è bastata che a scrivere il primo.
(Dalla prefazione del 1964)