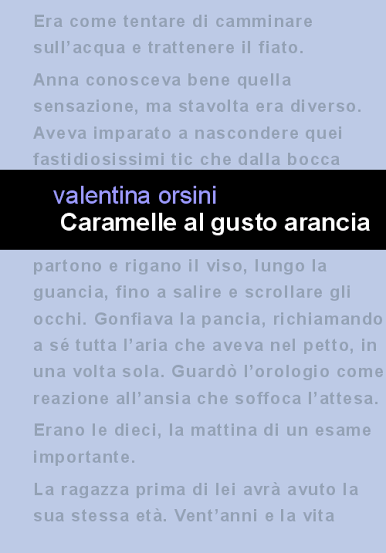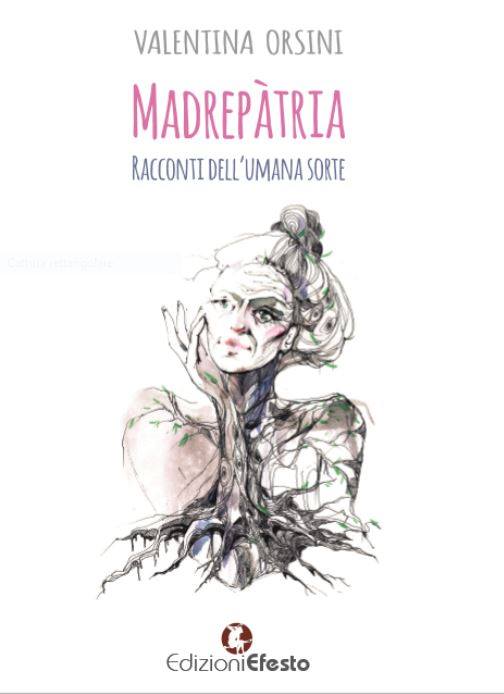Andare a rivangare gli incubi ricorrenti degli esseri umani, credo porti in superficie la natura di tutti. Le paure più attecchite e le più inverosimili. Tipo:"svegliarsi una mattina e vedere il mondo a pezzi - cioè peggio di come è attualmente - e rendersi conto che la gente no, non è sparita".
Tepiacerebbe.
L'impensabile viene tradotto in lamenti disumani e passi sbilenchi, volti frantumati, morti che camminano.
Zombie.
Paure queste che portano addirittura noi uomini a sorridere o, nei casi più disperati (vedi me), a investire tempo e risorse pur di garantirsi quelle quattro ore al giorno davanti alla tv, immobile quasi in stato comatoso, pur di recuperare non una, non due, bensì TUTTE le stagioni di The Walking Dead.
Ovvero zombie che camminano e rompono i maroni dalla mattina alla sera a quei poveri cristi sopravvissuti a chissà quale assurda catastrofe. E punto!
Ma dov'è il lecito e l'illecito quando si è davanti alla tv e non si trova ragione altrove se non lì, esattamente lì?
La realtà è che i nostri schermi, proiettando serie tv, attivano uno strano meccanismo per cui micidiali gas allucinogeni iniziano a viaggiare nell'aria. E tu respiri quella bomba stupefacente e, sempre tu, senza neanche accorgertene, arrivi a quel punto critico in cui tutti, prima o poi, dovranno trovarsi. Quello in cui gli episodi da vedere sono finiti. Esauriti. Terminati.
E non ti resta che aspettare un finale di stagione da 90', quello che poi segnerà la tua morte definitiva:
"la nuova stagione - un anno senza".
E la tua reazione è raccapricciante.
I tuoi genitori in sala a gridarti contro: "avevi detto un episodio e poi smetto quando voglio", "che delusione Vale, da te proprio non me l'aspettavo".
E tu lì a piangerti addosso, ma non per la delusione e la ramanzina dei tuoi, no. Perché pensi che la sera del finale di stagione tu sei a lavoro, e torni tardi. Ciò significa che dovrai registrare quell'ultimo maledetto episodio e vederlo dopo. E dopo significa "dopo che tutti gli altri lo hanno visto. E tu no".
La depressione è dietro l'angolo, tuttavia, c'è un aspetto positivo in tutta questa assurda storia...
Momento serietà.
Vedendo The Walking Dead ho iniziato ad abbandonare quel vecchio pregiudizio secondo il quale gli zombie, come genere cinematografico o seriale, non meriterebbero alcuna attenzione. Cose troppo splatter e trash per i miei gusti.
Ultime parole famose...
Dopo le esperienze più che felici, nel mondo seriale, con The Leftovers e True Detective, si è riaccesa in me la voglia di dannarmi l'anima a suon di "ancora uno, ancora un episodio!!!". La dipendenza vien da sé, si sa. E a forza di seguire la storia di Rick, del suo incubo e poi di tutti, ho capito che il sentimento più comune tra gli uomini, è la nostalgia delle cose passate.
Qui ovviamente è vestita e truccata tanto da non farsi vedere, perché dietro corpi squartati e sangue in ogni dove, viene quasi difficile pensare a un sentimento così delicato e silenzioso, come la nostalgia.
Eppure a ben vedere, è una costante in The Walking Dead.
Il mondo com'era prima sembra solo la vigilia della sua stessa morte, e il ricordo di quel mondo felice seppur imperfetto, tormenta i sopravvissuti.
La famiglia, compagni e fratelli pronti a morire l'uno per l'altro. Apprezzare le piccole cose, imparare a combattere con la rabbia di un leone e conservare quel briciolo di umanità. Affinché non ci si scordi mai di com'era prima. Anche nella storia più post apocalittica che si possa raccontare, anche in mezzo a zombie che camminano e fiotti di sangue, viene fuori la verità primitiva, semplice.
Che per quanto uno possa essere scaltro, in gamba e "sveglio", trova sempre uno più furbo pronto a fregarlo come volta le spalle. Che ci sarà sempre qualcuno di cui diffidare, e che distinguere i buoni dai cattivi è impresa impossibile.
Finisce quasi che tu dimentichi il motivo per cui tutto è cominciato. Gli zombie.
Perché a contare le vittime quasi fai fatica, a distinguere quelli morti azzannati da quelli morti ammazzati dall'accidia, dall'indifferenza e dalla cattiveria. Tutte virtù degli uomini. Dei vivi.
Ti chiedi costantemente cosa sia davvero l'umanità e, nel caso tu ci riesca, a capirlo, arrivi persino a provare pena e compassione per un putrefatto chiuso nel bagagliaio di un'auto e legato, inerme.
Scatta in te quel sentimento che porta a immaginare tutto ciò che un tempo riguardasse quel morto vivente, la nostalgia di una vita non tua. Ti rendi conto che tutti, zombie compresi, sono vittime delle scelte degli uomini. E che in qualsiasi mondo tu possa svegliarti la mattina, la tua più grande sfida sarà quella di guardarti bene intorno, ovunque ti trovi.
Soprattutto ora, che sei sveglio e la tv è spenta.
Perché questo non è il mondo degli uomini e degli zombie, ma il mondo degli uomini e no.
"Ciao Vale, sono la mamma di Davide, il compagno di classe di Luca. Ti ricordi?".
Chi sei?
Quanti zombie hai ucciso?
Quanti uomini?
Perché?